
Il 7 aprile scorso è stato il trentesimo anniversario del genocidio del Ruanda. Tutto inizia il 6 aprile 1994 quando due razzi colpiscono l’aereo che trasportava l’allora presidente del Ruanda Juvènal Habyarimana, di etnia Hutu e il suo omonimo del Burundi, Cyprien Ntaryamira. L’attacco, le cui responsabilità non sono mai state definitivamente chiarite, rappresentò, per la popolazione hutu, il pretesto per dare vita a un genocidio tra i più sanguinosi del secolo scorso. Dal giorno seguente le violenze degli Hutu – esercito, milizie, ma anche cittadini comuni – si abbatterono contro la minoranza Tutsi, vittima di una campagna di propaganda d’odio. In poco più di tre mesi furono uccisi più di 800mila tutsi, etnia minoritaria, tra uomini, donne, anziani e bambini.
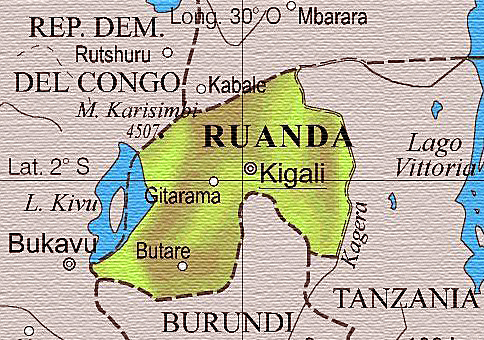 Jean-Paul Habimana, quando ebbe inizio il genocidio, aveva appena dieci anni. Oggi insegna religione a Milano. Su questa vicenda ha scritto un libro: “Nonostante la paura. Il genocidio dei tutsi e Riconciliazione in Ruanda” e al Sir ha raccontato la sua esperienza proprio in occasione dell’anniversario del massacro. “Io e il resto della mia famiglia apparteniamo all’etnia tutsi. Quando ebbe inizio il genocidio decidemmo di rifugiarci nella parrocchia. Dopo alcuni giorni, gli hutu arrivarono anche da noi. La prima cosa che fecero fu tagliare le tubature dell’acqua. Oltre alle uccisioni, abbiamo subito anche la fame e la sete. Sono uno dei pochi che in quella parrocchia è riuscito a sopravvivere. Ricordo che giorno una donna, una mia vicina di casa di etnia hutu, che non aveva partecipato al genocidio, venne in parrocchia per verificare se qualcuno era ancora vivo. Mi trovò e mi portò a casa sua assieme a mio fratello. Siamo rimasti lì pochissimi giorni perché poi ci scoprirono. Intorno a giugno fui spostato nel campo profughi di Nyarushishi dove poi mi raggiunsero mia mamma, i miei fratelli e le mie sorelle”. Solo nel settembre del 1994 Habimana ha avuto la possibilità di poter lasciare il campo profughi.
Jean-Paul Habimana, quando ebbe inizio il genocidio, aveva appena dieci anni. Oggi insegna religione a Milano. Su questa vicenda ha scritto un libro: “Nonostante la paura. Il genocidio dei tutsi e Riconciliazione in Ruanda” e al Sir ha raccontato la sua esperienza proprio in occasione dell’anniversario del massacro. “Io e il resto della mia famiglia apparteniamo all’etnia tutsi. Quando ebbe inizio il genocidio decidemmo di rifugiarci nella parrocchia. Dopo alcuni giorni, gli hutu arrivarono anche da noi. La prima cosa che fecero fu tagliare le tubature dell’acqua. Oltre alle uccisioni, abbiamo subito anche la fame e la sete. Sono uno dei pochi che in quella parrocchia è riuscito a sopravvivere. Ricordo che giorno una donna, una mia vicina di casa di etnia hutu, che non aveva partecipato al genocidio, venne in parrocchia per verificare se qualcuno era ancora vivo. Mi trovò e mi portò a casa sua assieme a mio fratello. Siamo rimasti lì pochissimi giorni perché poi ci scoprirono. Intorno a giugno fui spostato nel campo profughi di Nyarushishi dove poi mi raggiunsero mia mamma, i miei fratelli e le mie sorelle”. Solo nel settembre del 1994 Habimana ha avuto la possibilità di poter lasciare il campo profughi.
Chi invece non ha fatto più ritorno da questo massacro è stato suo padre. Di lui, nessuno ha saputo più nulla. “Ho sentito molto la sua mancanza – confida Habimana -. Potete immaginare cosa significhi per un bambino di dieci anni crescere senza il padre. Tuttavia, ho cercato di abbracciare questa mia croce e di andare avanti.
La Chiesa, specialmente dopo il genocidio, è stata tutto per me. Senza la preghiera, la mia vita non avrebbe avuto nessun senso. Tutti i giorni dopo il genocidio non facevo altro che pregare. Era l’unica nostra consolazione.
Oggi mi chiedo spesso come avrebbe fatto mia mamma, diventata vedova da giovane, ad andare avanti senza la preghiera. Pregare era la sua forza, come quella di tante altre donne e orfani. Per noi significava avere un contatto con Dio: Lui ci ha fatto vivere tutto questo per un motivo che non abbiamo ancora compreso ma ci ha fatto anche sopravvivere. Non ci ha mai deluso, ci ha messo sulle spalle l’esperienza più brutta che l’essere umano possa vivere ma ci ha regalato anche la vita”.
Habimana sottolinea come la Chiesa si sia spesa molto anche dal punto di vista comunitario in Ruanda. Subito dopo il genocidio, racconta come siano state istituite nel Paese le Imiryangoremezo, comunità ecclesiali di base, luoghi di ritrovo e condivisione dove i sacerdoti aiutavano le persone a parlare. Attraverso il dialogo con i superstiti al massacro si è cercato di riallacciare la comunicazione con le mogli degli assassini con l’obiettivo di approcciare una sorta di rinnovata convivenza tra le due popolazioni. Un processo che dopo trent’anni Habimana affronta ancora dentro di sé. “I miei sentimenti dipendono dalle giornate. Mi capita a volte di vivere diversi momenti di pace e riconciliazione. Purtroppo in questi giorni, specialmente quando si avvicina l’otto aprile, l’ultimo giorno in cui ho visto mio padre, non nascondo come invece emerga in me la rabbia.
Mi è capitato di incontrare degli assassini pentiti dei loro crimini, oggi liberi in Ruanda. A volte, pur essendo vicini di casa, vorrei non rispondere ai saluti. Però so che bisogna andare avanti. Ormai tutto questo è successo. Devo poter riuscire a perdonare perché altrimenti ci si fa più male”.
Oggi Habimana racconta della tragedia del Ruanda ai suoi studenti, spesso gli chiedono di raccontare le sue esperienze. “I libri che ho scritto sul genocidio li ho pensati proprio per loro. Spesso si stupiscono. Loro faticano a raccontare i propri piccoli grandi dolori, mentre io mi presento a loro come un libro aperto. Capisco comunque che raccontare questa storia non è una passeggiata. Durante i primi sei anni in Italia non ne ho parlato mai con nessuno. L’ho fatto quando mi sono sentito pronto. Tanti, ancora oggi, non riescono ad aprire bocca. La lezione che possiamo trarre da questa vicenda è che un genocidio si può scatenare anche all’interno di uno stesso popolo. Anche qui, in Italia, bisogna stare attenti e vigilare e non ritenere che vicende di questo tipo siano solo degli eventi avvenuti tempo fa e lontani da noi. Questo massacro infatti è nato e cresciuto tra gente che fino a un determinato giorno non si odiava. Gente che si salutava tutte le mattine, che andava insieme a prendere l’acqua alla stessa fontana, gente che viveva e faceva tutto insieme. Dico questo perché da vent’anni vivo nella comunità italiana, e vedo anche tante divisioni tra gente che ha tutto in comune”.












