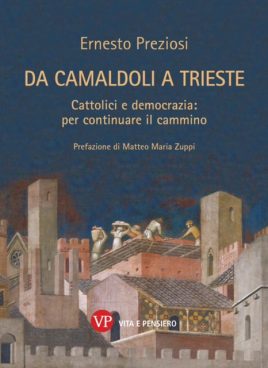Il tema scelto per la 50ª Settimana sociale che si terrà a Trieste dal 3 al 7 luglio – “Al cuore della democrazia. Partecipare tra storia e futuro” – offre l’occasione per rivisitare il cammino dai cattolici italiani nello Stato unitario. Tra gli strumenti che possono favorire l’approfondimento del tema, c’è il volume edito da Vita e Pensiero, “Da Camaldoli a Trieste. Cattolici e democrazia: per continuare il cammino” di Ernesto Preziosi.
Il testo offre una rapida panoramica del percorso compiuto dai cattolici italiani nel rapporto con la democrazia. Un percorso che va dall’estraneità, seguita alla stagione risorgimentale e interpretata dal “non expedit”, al confronto che si svolge all’inizio del ‘900, con i contributi di Giuseppe Toniolo, Romolo Murri e Luigi Sturzo, e alla fondazione del Partito Popolare nel 1919, fino al secondo dopoguerra quando, con la Resistenza al nazifascismo, inizia una stagione nuova che vede la nascita della Dc degasperiana.
Una stagione intensa, segnata da eventi significativi. Uno di questi è l’incontro, nel luglio 1943, di un gruppo di intellettuali cattolici nel monastero di Camaldoli. Dalle riflessioni di quei giorni e da una elaborazione rallentata dagli eventi bellici, uscirà nella primavera del 1945 il “Codice di Camaldoli”. Nel frattempo, con il radiomessaggio natalizio del 1944, Pio XII apre la strada alla scelta democratica. Il Papa afferma che i popoli resi “edotti da un’amara esperienza” si oppongono al potere dittatoriale e si aprono verso la “tendenza democratica”. Di lì a poco, nell’ottobre 1945, a Firenze riprendono, dopo una interruzione ventennale, le Settimane sociali con il tema “Cattolici e Costituente”.
Da allora il rapporto tra cattolici e democrazia ha attraversato diverse fasi: quelle in cui il partito di ispirazione cristiana ha avuto la responsabilità di guidare la ricostruzione e una lunga stagione di governi e di riforme fino agli anni della contestazione e del terrorismo, quindi la crisi che ha travolto le forme partitiche. È seguita una lunga diaspora in cui i cattolici si sono misurati con differenti scenari: dalle spinte separatiste della Lega prima maniera al confronto con forze politiche che hanno promosso l’antipolitica, a partiti avvitati intorno ai leader, al sorgere di forze populiste simpatizzanti per una democrazia plebiscitaria con tendenze che vanno nella direzione di democrazie illiberali, che fanno breccia nelle società scosse dai fenomeni di modernizzazione e in profonda trasformazione. Fasi diverse in cui la democrazia ha visto crescere fattori di crisi, temi su cui sono state dedicate più edizioni delle Settimane sociali. Non è difficile riconoscere come la democrazia costituisca il “fil rouge” che collega il periodo della Seconda Guerra mondiale ai nostri giorni, quando i cattolici sono chiamati a farsi carico della crisi della democrazia rappresentativa.
L’esempio che viene dall’incontro di Camaldoli del 1943, infatti, dice della capacità avuta allora dai cattolici di compiere un’opera vasta di “alfabetizzazione democratica”, “un’aratura civile” come la chiamava Pio XII, che si giovò in modo determinante della rete associativa cattolica (a cominciare dall’Ac e poi dalle risorte formazioni sindacali, e così Acli, Coldiretti, Cif…). Se da un lato, quindi, la riflessione culturale risultò utile a quanti si trovarono nel ruolo di costituenti e a ricoprire, nei vari livelli, incarichi politici, la diffusione dei contenuti del Codice e della Settimana sociale a livello popolare favorì la maturazione di quel consenso che in democrazia è fondamentale.
La Settimana sociale di Trieste è un’occasione per guardare al lascito di questo lungo cammino senza nostalgie, per contribuire a pensare la democrazia in un mondo profondamente mutato e in cerca di nuove chiavi di lettura.
La crisi della democrazia, infatti, non è un fenomeno solo italiano, è evidente anche in Europa dove si registrano tendenze nazionalistiche che indeboliscono il progetto europeo e dove la Commissione Ue ha promosso un intervento legislativo per migliorare la trasparenza e la responsabilità democratica delle attività di rappresentanza. Da più parti, e segnatamente nella prolusione del presidente della Cei, card. Matteo Zuppi, al convegno di un anno fa per gli 80 anni del Codice di Camaldoli, viene l’invito a promuovere una “Camaldoli europea”. Anche se non si tratta di un obiettivo di facile realizzazione, può avere una sua utilità nel favorire, oltre che il dialogo tra i credenti dei vari Paesi, anche un’interessante spinta verso una stagione di rilancio dell’unità europea. Unità che, con ogni evidenza, può fare un passo avanti e progredire anche grazie a un contributo delle tradizioni politiche di matrice cattolica alla costruzione europea, per una maturazione politica condivisa e compiutamente democratica. In tal senso sono interessanti i risultati della Conferenza sul futuro dell’Unione. Le proposte formulate (a cominciare dalla riforma dei Trattati) potrebbero costruire una democrazia capace di sostanziare compiutamente una cittadinanza europea che completi e dia senso a quelle nazionali.
Il volume di Preziosi si conclude con la presentazione di cinque schede in cui la democrazia è declinata in altrettanti aspetti: “Cattolici, politica, democrazia” per cogliere la dinamica storica da cui proveniamo ed il nesso tra fede e politica; “Democrazia e partecipazione dei cittadini” per individuare i valori della democrazia partecipativa, comprendere le diverse interpretazioni della crisi e le vie per superarla; “Democrazia tra Europa, occidente e geopolitica mondiale” per inquadrare la situazione italiana nel più ampio contesto europeo e mondiale; “Democrazia ed economia” per considerare lo stretto (ma poco evidente) nesso tra la dimensione politica e le dinamiche di lavoro, produzione, commercio, finanza; “Democrazia e sistema informativo/formativo” per valutare la compatibilità tra democrazia partecipativa, mondo della comunicazione e sistema educativo/scolastico.