
 Il grande tema dell’ “altro” ha avuto riprese inaspettate, come, a fine Settecento, il “Viaggio intorno alla mia camera” di Xavier de Maistre, a sua volta divenuto ispirazione (con il merito della divulgazione, cosa oggi preziosissima, trattandosi di una letteratura dimenticata) del famoso “animale che mi porto dentro / non mi fa vivere felice mai/ si prende tutto anche il caffè” del mai troppo rimpianto Battiato.
Il grande tema dell’ “altro” ha avuto riprese inaspettate, come, a fine Settecento, il “Viaggio intorno alla mia camera” di Xavier de Maistre, a sua volta divenuto ispirazione (con il merito della divulgazione, cosa oggi preziosissima, trattandosi di una letteratura dimenticata) del famoso “animale che mi porto dentro / non mi fa vivere felice mai/ si prende tutto anche il caffè” del mai troppo rimpianto Battiato.
In realtà, la letteratura abbonda di casi di altro-sé o second self che agiscono al posto nostro, o sarebbe il caso di dire al posto della presunta identità permanente: cosa su cui Lautréamont, Bergson, Pirandello, Svevo, Stevenson, Tozzi e molti altri avrebbero da ridire assai.
Un altro racconto che ci riporta a questo grande tema è il recente “Poco a me stesso” (Marsilio, 234 pagine, 16 euro) di Alessandro Zaccuri. Uno scrittore esperto di letteratura – scrive su Avvenire ed è direttore della Comunicazione per l’Università Cattolica di Milano – che ha affrontato già con il suo precedente “La quercia di Bruegel” la dimensione dell’altro come opposizione, talvolta salvifica, alle nostre rigidità prospettiche. Qui, svelare l’identità, se così si può dire, del sé sconosciuto, sarebbe anticipare una conclusione che coinvolge Giulia Beccaria, figlia del grande illuminista Cesare e madre di Alessandro Manzoni, donna che ha rifiutato un destino eterodiretto, fuggendo da un matrimonio non deciso da lei e scegliendo un volontario esilio in Francia al seguito dell’uomo amato, Carlo Imbonati. Una vita per quei tempi piuttosto fuori dagli schemi e che ha coinvolto anche la possibile paternità di Alessandro, secondo molti figlio naturale di Giovanni Verri, fratello minore e meno noto di due grandi protagonisti dell’illuminismo milanese, e non solo milanese: Alessandro e Pietro. La storia di Zaccuri ci porta tra gente più o meno nota, tra i ricordi di Mesmer e la presenza di una donna come Giulia che, per merito dell’autore, non appare, come avrebbe rischiato in una penna superficiale, nelle vesti di antica libertina, cosa che peraltro non era, e protofemminista, ma semplicemente come una persona che ha tentato di dare un senso alla propria vita: con rimozioni destinate però a riaffacciarsi nella Milano degli anni Quaranta dell’Ottocento. E soprattutto con un motivo centrale, quello del gioco, che mette assieme esistenza reale, per chi conosce bene la vita di Manzoni prima della conversione, e finizione. Pregio del romanzo è quello di presentarci personaggi più o meno reali (ma è davvero possibile in letteratura la realtà di un personaggio? Manzoni stesso entrò in crisi profonda per questo, e per questo “I promessi sposi” sono il suo unico romanzo) che interagiscono tra invenzione e storia, con un protagonista che sembra quasi essere il simbolo di questa continua mescolanza, perché è un inventore di sé, e che però scopre la verità degli altri.
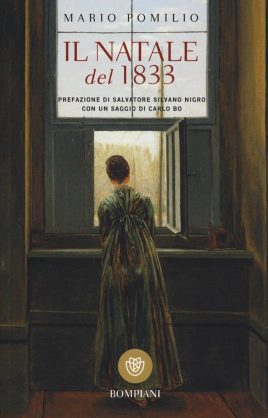 Per rimanere in tema manzoniano, e quindi ormai classico, come non servirci di un classico “minore”, nel senso di troppo contemporaneo, siamo nel 1983 – e c’è di mezzo anche un premio Strega -, per comprendere meglio il tema della visione dell’altro? “Il Natale del 1833” di Mario Pomilio (Bompiani, 148 pagine, 9 euro) è infatti il romanzo narrato dal punto di vista di una protagonista del racconto di Zaccuri, Giulia Beccaria. È lei che racconta attraverso l’espediente epistolare, un elemento diffusissimo nella creazione narrativa (basti pensare ad un altro libro di Pomilio, “Il quinto Evangelio”, o a “Il nome della Rosa” di Eco, andando indietro nel tempo fino al Seicento) la sua percezione del dolore di Alessandro per la scomparsa dell’amata Enrichetta, un dolore poi amplificato dalla morte, qualche mese più tardi, della figlia primogenita, che era andata in sposa a Massimo d’Azeglio. Come ha giustamente scritto Giancarlo Vigorelli, questo di Pomilio è un “romanzo-saggio che ha per sfondo il Manzoni”, e la parola sfondo non è a caso: qui regna intanto l’abissale interrogativo di una madre che ha fatto della ricerca dell’amore una battaglia contro l’ipocrisia della buona società, e che aveva visto anche lei morire l’uomo amato. Un dolore che attraversa l’amore, in tutte le sue sfaccettature, il mistero della sofferenza apparentemente senza senso, e gli interrogativi, ancora oggi aperti, sulla figura di Manzoni. Il quale, e Giulia nelle sue lettere lo mette bene in evidenza, è provato da quella pena e dalle domande sul volere di Dio, e su Dio stesso. Il grande tema di Giobbe si fonde sulla tentazione dell’abbandono della fede e su una conseguenza che genialmente qui Pomilio appena accenna con una sorta di richiamo alla seicentesca sprezzatura, al non dar peso apparentemente alla rilevanza di una azione. Perché qui si staglia sull’orizzonte dei significati la rinunzia di Alessandro a scrivere altro in campo narrativo. Al momento del “Natale del 1833” siamo a metà strada tra l’edizione chiamata ventisettana e la quarantana del capolavoro manzoniano. Poi, nel 1850, con il travagliato “Discorso del romanzo storico”, la sofferta decisione: non è possibile mettere insieme invenzione e storia. Il che, secondo alcuni, è un modo spiccio per liquidare un altro tentativo: quello di giustificare il male e di capire perché questo male colpisca anche e soprattutto chi pratica il bene. Il dolore della perdita di moglie e figlia nel giro di poco tempo, sembra dire la Giulia raccontata da Pomilio, rende impossibile continuare la narrazione di una storia, quella privata, che fondendosi con quella maiuscola, sembra togliere qualsiasi possibilità di capire. Ma forse è proprio questo “capire” che Manzoni tenta di mettere da parte, come fattore umano non in grado di penetrare nel Senso che talvolta sembra prendersi gioco di quella antica pretesa di assoggettare la realtà alla logica e alla ratio d’occidente.
Per rimanere in tema manzoniano, e quindi ormai classico, come non servirci di un classico “minore”, nel senso di troppo contemporaneo, siamo nel 1983 – e c’è di mezzo anche un premio Strega -, per comprendere meglio il tema della visione dell’altro? “Il Natale del 1833” di Mario Pomilio (Bompiani, 148 pagine, 9 euro) è infatti il romanzo narrato dal punto di vista di una protagonista del racconto di Zaccuri, Giulia Beccaria. È lei che racconta attraverso l’espediente epistolare, un elemento diffusissimo nella creazione narrativa (basti pensare ad un altro libro di Pomilio, “Il quinto Evangelio”, o a “Il nome della Rosa” di Eco, andando indietro nel tempo fino al Seicento) la sua percezione del dolore di Alessandro per la scomparsa dell’amata Enrichetta, un dolore poi amplificato dalla morte, qualche mese più tardi, della figlia primogenita, che era andata in sposa a Massimo d’Azeglio. Come ha giustamente scritto Giancarlo Vigorelli, questo di Pomilio è un “romanzo-saggio che ha per sfondo il Manzoni”, e la parola sfondo non è a caso: qui regna intanto l’abissale interrogativo di una madre che ha fatto della ricerca dell’amore una battaglia contro l’ipocrisia della buona società, e che aveva visto anche lei morire l’uomo amato. Un dolore che attraversa l’amore, in tutte le sue sfaccettature, il mistero della sofferenza apparentemente senza senso, e gli interrogativi, ancora oggi aperti, sulla figura di Manzoni. Il quale, e Giulia nelle sue lettere lo mette bene in evidenza, è provato da quella pena e dalle domande sul volere di Dio, e su Dio stesso. Il grande tema di Giobbe si fonde sulla tentazione dell’abbandono della fede e su una conseguenza che genialmente qui Pomilio appena accenna con una sorta di richiamo alla seicentesca sprezzatura, al non dar peso apparentemente alla rilevanza di una azione. Perché qui si staglia sull’orizzonte dei significati la rinunzia di Alessandro a scrivere altro in campo narrativo. Al momento del “Natale del 1833” siamo a metà strada tra l’edizione chiamata ventisettana e la quarantana del capolavoro manzoniano. Poi, nel 1850, con il travagliato “Discorso del romanzo storico”, la sofferta decisione: non è possibile mettere insieme invenzione e storia. Il che, secondo alcuni, è un modo spiccio per liquidare un altro tentativo: quello di giustificare il male e di capire perché questo male colpisca anche e soprattutto chi pratica il bene. Il dolore della perdita di moglie e figlia nel giro di poco tempo, sembra dire la Giulia raccontata da Pomilio, rende impossibile continuare la narrazione di una storia, quella privata, che fondendosi con quella maiuscola, sembra togliere qualsiasi possibilità di capire. Ma forse è proprio questo “capire” che Manzoni tenta di mettere da parte, come fattore umano non in grado di penetrare nel Senso che talvolta sembra prendersi gioco di quella antica pretesa di assoggettare la realtà alla logica e alla ratio d’occidente.












