
 “Il provvedimento è stato pubblicato in un periodo quasi feriale, lontano da ogni grande consultazione popolare, sia in Italia che fuori, in modo da non dare esca alle solite accuse di manovre pre-elettorali pro o contro l’uno o l’altro partito”. Le parole di Meli Lupi di Soragna, ambasciatore italiano presso la Santa Sede, riguardanti la famosa “scomunica” promulgata il 13 luglio 1949, sono forse la sintesi più pertinente di un atto che aveva impegnato tutte le componenti del Vaticano, Pio XII in prima persona, alla ricerca di un modo di fronteggiare il comunismo, soprattutto ad est, e nel contempo di non creare una spaccatura fatale tra il mondo cattolico e le due maggiori forze della sinistra italiana, comunisti e socialisti. E “La scomunica ai comunisti. Protagonisti e retroscena nelle carte riemerse del Sant’Offizio” ( San Paolo, 370 pagine, 25 euro) è il titolo del libro di Cesare Catananti, già direttore del Policlinico Gemelli e docente di storia della medicina, da sempre impegnato nella ricostruzione di alcuni momenti della storia del Vaticano. Un libro che ha un rilevante merito, oltre a quello di far conoscere finalmente i contenuti dei documenti riguardanti il pontificato di Pio XII: quello di permettere ai lettori, soprattutto i più giovani, la conoscenza di un periodo della storia mondiale oggetto di visioni e revisioni, di sguardi prospettici viziati dalle appartenenze politiche e ideologiche e di grandi fermenti all’interno del cattolicesimo stesso. Non è un caso che un rilevante spazio sia dedicato a quelle esperienze di confine tra cattolicesimo e comunismo, come i “cattolici comunisti” poi “cristiani di sinistra” di Rodano, Ossicini, Tatò, Balbo ed altri, che tanto sconcerto causarono non solo in Vaticano e nella Dc, ma all’interno dello stesso Partito Comunista: erano visti come un impedimento alla “divisione dei compiti” nello scenario politico tra gli ultimi anni della guerra e i Cinquanta. Quel decreto, che tra l’altro il Pci, almeno ufficialmente, sembrò ignorare, anche perché da un certo punto di vista metteva le carte in tavola e dirimeva certe ambiguità presenti anche dentro il monolite comunista, aveva radici non solo legate alla politica interna, ma anche e soprattutto a quella estera. In realtà a preoccupare i vertici vaticani erano soprattutto le notizie che venivano dai paesi satelliti dell’Urss e dalle zone del nostro nord-est nord italiano inglobate dal regime di Tito, e che parlavano di persecuzioni, uccisioni, violazioni di chiese, propaganda materialista e atea che rendeva, se non impossibile, almeno molto problematica la fede oltrecortina. Un libro questo che va letto attentamente perché i drammi umani e collettivi sono accompagnati da una serrata e quasi filologica escursione dei documenti ritrovati.
“Il provvedimento è stato pubblicato in un periodo quasi feriale, lontano da ogni grande consultazione popolare, sia in Italia che fuori, in modo da non dare esca alle solite accuse di manovre pre-elettorali pro o contro l’uno o l’altro partito”. Le parole di Meli Lupi di Soragna, ambasciatore italiano presso la Santa Sede, riguardanti la famosa “scomunica” promulgata il 13 luglio 1949, sono forse la sintesi più pertinente di un atto che aveva impegnato tutte le componenti del Vaticano, Pio XII in prima persona, alla ricerca di un modo di fronteggiare il comunismo, soprattutto ad est, e nel contempo di non creare una spaccatura fatale tra il mondo cattolico e le due maggiori forze della sinistra italiana, comunisti e socialisti. E “La scomunica ai comunisti. Protagonisti e retroscena nelle carte riemerse del Sant’Offizio” ( San Paolo, 370 pagine, 25 euro) è il titolo del libro di Cesare Catananti, già direttore del Policlinico Gemelli e docente di storia della medicina, da sempre impegnato nella ricostruzione di alcuni momenti della storia del Vaticano. Un libro che ha un rilevante merito, oltre a quello di far conoscere finalmente i contenuti dei documenti riguardanti il pontificato di Pio XII: quello di permettere ai lettori, soprattutto i più giovani, la conoscenza di un periodo della storia mondiale oggetto di visioni e revisioni, di sguardi prospettici viziati dalle appartenenze politiche e ideologiche e di grandi fermenti all’interno del cattolicesimo stesso. Non è un caso che un rilevante spazio sia dedicato a quelle esperienze di confine tra cattolicesimo e comunismo, come i “cattolici comunisti” poi “cristiani di sinistra” di Rodano, Ossicini, Tatò, Balbo ed altri, che tanto sconcerto causarono non solo in Vaticano e nella Dc, ma all’interno dello stesso Partito Comunista: erano visti come un impedimento alla “divisione dei compiti” nello scenario politico tra gli ultimi anni della guerra e i Cinquanta. Quel decreto, che tra l’altro il Pci, almeno ufficialmente, sembrò ignorare, anche perché da un certo punto di vista metteva le carte in tavola e dirimeva certe ambiguità presenti anche dentro il monolite comunista, aveva radici non solo legate alla politica interna, ma anche e soprattutto a quella estera. In realtà a preoccupare i vertici vaticani erano soprattutto le notizie che venivano dai paesi satelliti dell’Urss e dalle zone del nostro nord-est nord italiano inglobate dal regime di Tito, e che parlavano di persecuzioni, uccisioni, violazioni di chiese, propaganda materialista e atea che rendeva, se non impossibile, almeno molto problematica la fede oltrecortina. Un libro questo che va letto attentamente perché i drammi umani e collettivi sono accompagnati da una serrata e quasi filologica escursione dei documenti ritrovati.
Ma prima? Prima del secondo e per alcuni aspetti difficile da dire, per l’orrore di alcune “soluzioni”, macello mondiale? Quali erano le reazioni degli scrittori non direttamente impegnati in politica? Quali possibili alternative gli uomini di cultura più sensibili alle voci del loro tempo ma anche alle ragioni di un eterno umanesimo proclamate nel secolo precedente da Goethe, avevano proposto prima ancora del concretizzarsi del nazismo? I cento anni del Siddharta (Adelphi, 197 pagine, trad. di M. Mila) di Herman Hesse (1877-1962) ci aiutano a capirlo. 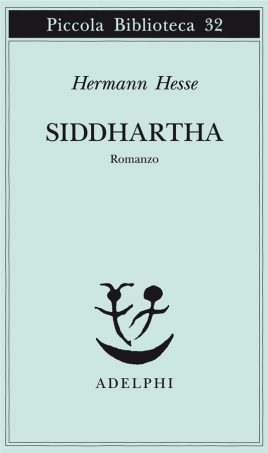 La storia del “figlio del Brahmino” che passa da esperienza ad esperienza, alla ricerca dell’indicibile fusione con il tutto è stata letta di volta in volta come fascinazione del pensiero buddista e induista (Hesse visitò l’India nel 1911), come scaltro breviario mistico per cavalcare la deriva irrazionalista, come anticipazione del ’68 e della generazione dei fiori, che in effetti riscoprì ed amò questo libro, non è in realtà solo questo. Perché qui non si tratta solo di India, ma di una più profonda e antica aspirazione di Hesse all’autentico, alla fusione con il tutto, alla rinuncia al sé teso solo ai piaceri materiali, all’amore per la natura come dono divino. In Siddharta precipita anche l’esperienza dei due viaggi in Italia che lo scrittore tedesco ma con nazionalità elvetica aveva compiuto nel 1901 e due anni dopo: soprattutto in quest’ultimo Hesse aveva approfondito ad Assisi la conoscenza del messaggio spirituale di Francesco e ne era rimasto talmente affascinato da scrivere tre storie, raccolte poi da noi con il titolo di “Francesco d’Assisi” (Newton, 91 pagine, trad. di F. Ricci e M. Ulivieri). La rinuncia, l’accettazione, il passaggio continuo al di là delle illusioni, la preghiera, la povertà di Siddharta recano con sé qualcosa del fascino del Poverello, del “saluto divino” che incarnava con la sua scelta di diventare creatura senza pensieri del domani. Siddharta ci insegna a vedere negli altri, nei non potenti, negli sfortunati, negli umili come il barcaiolo Vasudeva, quella traccia divina che ci dice, a saperle ascoltare, molte più cose di quanto si possa immaginare. L’appartenenza di questo libro al filone della ricerca delle radici comuni non va nel senso del tentativo di trovare continuità razziale tra le popolazioni indo-iraniche e quelle germaniche nella propaganda hitleriana, ma in quello di rivelare come già nel sesto secolo prima di Cristo lo scandalo della spoliazione del vecchio sé aveva percorso il mondo. Molti equivoci sarebbero stati evitati si fosse letto questo senso, e non altri, nella ricerca di comunione con il tutto del giovane brahmino, nella rinuncia di Francesco, nella loro riscoperta da parte di uno scrittore che aveva dedicato Siddharta a Romain Rolland, uno dei campioni della resistenza alla guerra e all’odio.
La storia del “figlio del Brahmino” che passa da esperienza ad esperienza, alla ricerca dell’indicibile fusione con il tutto è stata letta di volta in volta come fascinazione del pensiero buddista e induista (Hesse visitò l’India nel 1911), come scaltro breviario mistico per cavalcare la deriva irrazionalista, come anticipazione del ’68 e della generazione dei fiori, che in effetti riscoprì ed amò questo libro, non è in realtà solo questo. Perché qui non si tratta solo di India, ma di una più profonda e antica aspirazione di Hesse all’autentico, alla fusione con il tutto, alla rinuncia al sé teso solo ai piaceri materiali, all’amore per la natura come dono divino. In Siddharta precipita anche l’esperienza dei due viaggi in Italia che lo scrittore tedesco ma con nazionalità elvetica aveva compiuto nel 1901 e due anni dopo: soprattutto in quest’ultimo Hesse aveva approfondito ad Assisi la conoscenza del messaggio spirituale di Francesco e ne era rimasto talmente affascinato da scrivere tre storie, raccolte poi da noi con il titolo di “Francesco d’Assisi” (Newton, 91 pagine, trad. di F. Ricci e M. Ulivieri). La rinuncia, l’accettazione, il passaggio continuo al di là delle illusioni, la preghiera, la povertà di Siddharta recano con sé qualcosa del fascino del Poverello, del “saluto divino” che incarnava con la sua scelta di diventare creatura senza pensieri del domani. Siddharta ci insegna a vedere negli altri, nei non potenti, negli sfortunati, negli umili come il barcaiolo Vasudeva, quella traccia divina che ci dice, a saperle ascoltare, molte più cose di quanto si possa immaginare. L’appartenenza di questo libro al filone della ricerca delle radici comuni non va nel senso del tentativo di trovare continuità razziale tra le popolazioni indo-iraniche e quelle germaniche nella propaganda hitleriana, ma in quello di rivelare come già nel sesto secolo prima di Cristo lo scandalo della spoliazione del vecchio sé aveva percorso il mondo. Molti equivoci sarebbero stati evitati si fosse letto questo senso, e non altri, nella ricerca di comunione con il tutto del giovane brahmino, nella rinuncia di Francesco, nella loro riscoperta da parte di uno scrittore che aveva dedicato Siddharta a Romain Rolland, uno dei campioni della resistenza alla guerra e all’odio.












