
Hannah Arendt ci aveva avvertito della possibile banalità del male, a proposito dei carnefici nazisti: a sua volta Bruno Nacci narra in  “Destini. La fatalità del male”, (Edizioni Ares, 192 pagine, 16 euro), tenendo conto di elementi storici, quella apparente banalità in due di quei carnefici, anzi del loro capo e del numero due per un certo periodo, Albert Speer. Ma non solo l’incubo nazista. Perché l’autore, seguendo cronache e testimonianze dirette, ci mostra un’altra faccia di quel male, incarnata dal comunismo estremo di Pol Pot, che insanguinò la Cambogia con la sua feroce dittatura, tenuta in vita grazie a esecuzioni sommarie, torture, deportazioni, e ad una cifra di vittime che secondo alcuni si avvicina ai due milioni di persone. Eppure il tiranno assetato di sangue, ai tempi dei suoi studi alla Sorbona, era un timido giovanotto che amava giocare a pallone con i suoi connazionali e macinava chilometri in campo, senza tradire mai nessuna fatica; oltretutto non mostrò mai una personalità aggressiva, ma anzi, lasciava parlare tutti, ed ascoltava davvero quello che gli altri dicevano. Per non parlare del generale vietnamita reso famoso dall’istantanea che lo ritraeva mentre sparava alla testa di un vietcong, che poi diviene un ristoratore in Virginia e incontra proprio colui che lo aveva per così dire immortalato nella storia delle atrocità umane. E infine, ma in capo d’opera, per i motivi che il lettore comprenderà, la dibattuta questione dell’epistolario tra Seneca e san Paolo: sono lettere vere, tolte le due di cui ormai si è praticamente appurata la improbabilità? Nacci da parte sua non entra nell’agone filologico, ci mostra semplicemente un filosofo che in una sua lettera all’apostolo confessa di subire la fascinazione di un percorso in cui la fatalità stoica è posta in ombra da un nuovo messaggio. Non più ampi sistemi di pensiero, non più cedimenti al potere, come aveva dovuto fare in un recente prima: il suo male è stato quello di cercare di ottenere e mantenere a tutti i costi quel ruolo dominante, lasciando inevitabilmente vittime dietro la lotta per la sopravvivenza nelle aule imperiali. Un male forse minore, potrebbe pensare il lettore, se non fosse che quella concezione dell’ineluttabilità del male estremo per mantenere il potere, somiglia, in questo libro, alla necessità di Pol Pot o di Hitler di rappresentare la volontà del popolo. Con i risultati che abbiamo purtroppo potuto constatare.
“Destini. La fatalità del male”, (Edizioni Ares, 192 pagine, 16 euro), tenendo conto di elementi storici, quella apparente banalità in due di quei carnefici, anzi del loro capo e del numero due per un certo periodo, Albert Speer. Ma non solo l’incubo nazista. Perché l’autore, seguendo cronache e testimonianze dirette, ci mostra un’altra faccia di quel male, incarnata dal comunismo estremo di Pol Pot, che insanguinò la Cambogia con la sua feroce dittatura, tenuta in vita grazie a esecuzioni sommarie, torture, deportazioni, e ad una cifra di vittime che secondo alcuni si avvicina ai due milioni di persone. Eppure il tiranno assetato di sangue, ai tempi dei suoi studi alla Sorbona, era un timido giovanotto che amava giocare a pallone con i suoi connazionali e macinava chilometri in campo, senza tradire mai nessuna fatica; oltretutto non mostrò mai una personalità aggressiva, ma anzi, lasciava parlare tutti, ed ascoltava davvero quello che gli altri dicevano. Per non parlare del generale vietnamita reso famoso dall’istantanea che lo ritraeva mentre sparava alla testa di un vietcong, che poi diviene un ristoratore in Virginia e incontra proprio colui che lo aveva per così dire immortalato nella storia delle atrocità umane. E infine, ma in capo d’opera, per i motivi che il lettore comprenderà, la dibattuta questione dell’epistolario tra Seneca e san Paolo: sono lettere vere, tolte le due di cui ormai si è praticamente appurata la improbabilità? Nacci da parte sua non entra nell’agone filologico, ci mostra semplicemente un filosofo che in una sua lettera all’apostolo confessa di subire la fascinazione di un percorso in cui la fatalità stoica è posta in ombra da un nuovo messaggio. Non più ampi sistemi di pensiero, non più cedimenti al potere, come aveva dovuto fare in un recente prima: il suo male è stato quello di cercare di ottenere e mantenere a tutti i costi quel ruolo dominante, lasciando inevitabilmente vittime dietro la lotta per la sopravvivenza nelle aule imperiali. Un male forse minore, potrebbe pensare il lettore, se non fosse che quella concezione dell’ineluttabilità del male estremo per mantenere il potere, somiglia, in questo libro, alla necessità di Pol Pot o di Hitler di rappresentare la volontà del popolo. Con i risultati che abbiamo purtroppo potuto constatare.
 L’umiltà appare da sempre come una delle possibilità di resistenza al male, che, come abbiamo visto, può nascere dal desiderio di potere, di gloria, o dalla conservazione dei beni, materiali o no. “Il falegname di Nazareth” (San Paolo, 141 pagine, 14 euro) di Olivier De Gendre fa al caso nostro: non pura agiografia, ma neanche racconto nel senso tradizionale del termine, perché l’autore – che ci ha lasciato nel 2014 –ha voluto dipingere uno squarcio di vita comune e nello stesso tempo invasa dall’Altro. De Gendre, da sempre avvezzo alla narrazione del sacro e dei suoi “rischi” nel qui e nell’ora (e non a caso un suo libro-meditazione si intitola “Il rischio di Dio”) presenta, con grande semplicità, tratti di una vita in cui un uomo, assai giovane, in contrasto con la narrazione che voleva Giuseppe attempato, diviene padre e nello stesso tempo affronta un destino in cui quella sua speciale paternità attraversa l’Oltre. Le Gendre ha il grande merito di accompagnarci in una visione fatta di pezzi di realtà e contemporaneamente di sottile analisi del profondo, soprattutto quando il Falegname finalmente è colto nel suo arrendersi alla vita, all’altro e a quello che si distendeva nella sua storia come inesplicabile. Né un santino vecchio stile, quindi, né una riduzione a umano troppo umano, ma la capacità di cogliere un uomo nel momento in cui avverte che non era più il caso di rimanere legato a progetti, sogni, utopie, ma di arrendersi di fronte alla bellezza di una famiglia che pone ogni giorno la realizzazione di altri sogni: il sorriso e la corsa verso le sue braccia di un bambino, che talvolta si immerge in pensieri misteriosi e inaccessibili, la compagnia silente ma tangibile di una donna che condivide tutto, pericoli e piccole gioie. “Quelli che passano il loro tempo a desiderare e sono delusi quando hanno ottenuto” è una frase-spia che dimostra come tutta una filosofia apparentemente lontana dal messaggio cristiano, come quella di Schopenhauer, solo per fare un esempio, possa essere colta nella sua capacità di cogliere aspetti profondi e pragmatici della nostra esistenza, come l’accettazione non passiva, ma consapevole, del dono di darsi all’altro. Un Giuseppe lontano dall’iconografia ufficiale, reso ancora più affascinante dalla scelta della stupenda illustrazione di copertina (il san Giuseppe e Gesù bambino di Pietro Annigoni nella basilica di San Lorenzo a Firenze), che ci apre nuovi sentieri di avvicinamento al sacro dei nostri giorni. E nello stesso tempo ci presenta una umana, profonda antitesi al male.
L’umiltà appare da sempre come una delle possibilità di resistenza al male, che, come abbiamo visto, può nascere dal desiderio di potere, di gloria, o dalla conservazione dei beni, materiali o no. “Il falegname di Nazareth” (San Paolo, 141 pagine, 14 euro) di Olivier De Gendre fa al caso nostro: non pura agiografia, ma neanche racconto nel senso tradizionale del termine, perché l’autore – che ci ha lasciato nel 2014 –ha voluto dipingere uno squarcio di vita comune e nello stesso tempo invasa dall’Altro. De Gendre, da sempre avvezzo alla narrazione del sacro e dei suoi “rischi” nel qui e nell’ora (e non a caso un suo libro-meditazione si intitola “Il rischio di Dio”) presenta, con grande semplicità, tratti di una vita in cui un uomo, assai giovane, in contrasto con la narrazione che voleva Giuseppe attempato, diviene padre e nello stesso tempo affronta un destino in cui quella sua speciale paternità attraversa l’Oltre. Le Gendre ha il grande merito di accompagnarci in una visione fatta di pezzi di realtà e contemporaneamente di sottile analisi del profondo, soprattutto quando il Falegname finalmente è colto nel suo arrendersi alla vita, all’altro e a quello che si distendeva nella sua storia come inesplicabile. Né un santino vecchio stile, quindi, né una riduzione a umano troppo umano, ma la capacità di cogliere un uomo nel momento in cui avverte che non era più il caso di rimanere legato a progetti, sogni, utopie, ma di arrendersi di fronte alla bellezza di una famiglia che pone ogni giorno la realizzazione di altri sogni: il sorriso e la corsa verso le sue braccia di un bambino, che talvolta si immerge in pensieri misteriosi e inaccessibili, la compagnia silente ma tangibile di una donna che condivide tutto, pericoli e piccole gioie. “Quelli che passano il loro tempo a desiderare e sono delusi quando hanno ottenuto” è una frase-spia che dimostra come tutta una filosofia apparentemente lontana dal messaggio cristiano, come quella di Schopenhauer, solo per fare un esempio, possa essere colta nella sua capacità di cogliere aspetti profondi e pragmatici della nostra esistenza, come l’accettazione non passiva, ma consapevole, del dono di darsi all’altro. Un Giuseppe lontano dall’iconografia ufficiale, reso ancora più affascinante dalla scelta della stupenda illustrazione di copertina (il san Giuseppe e Gesù bambino di Pietro Annigoni nella basilica di San Lorenzo a Firenze), che ci apre nuovi sentieri di avvicinamento al sacro dei nostri giorni. E nello stesso tempo ci presenta una umana, profonda antitesi al male.
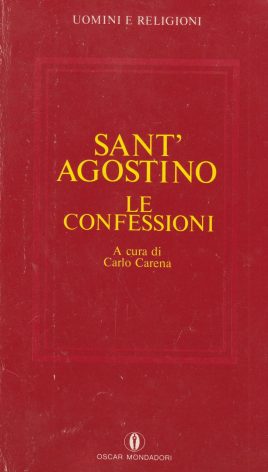 Questo cammino di allontanamento dal male ha radici profonde, divenute punti di riferimento di tutto ciò che è venuto dopo: una di queste è incarnata dalle Confessioni di Sant’Agostino. Non solo perché questo libro di straordinaria auto-analisi, in anticipo di molti secoli su Freud, ha influenzato molta letteratura, anche quella non direttamente coinvolta nel progetto cristiano, come il “Tardi ti ho amato” di Ethel Mannin, (per non parlare del “Secretum” di Petrarca) ma in quanto rappresenta un vero e proprio cammino di terapia contro il male. Ecco perché questo libro prodigiosamente capace di parlare a tutti e in tutte le epoche andrebbe riletto ancora oggi. Ve ne sono diverse edizioni (quella in nostro possesso è una “antica” – 1989 – ristampa Mondadori curata da Carlo Carena, ma ve ne sono più recenti di Rizzoli, Bompiani, Newton Compton ed altri), con o senza il testo latino a fronte, che ci permettono di riprendere fiato nella corsa sempre più virtuale e solitaria nel bosco informatico, dove si nascondono i lupi cattivi della solitudine e della depressione. O dell’apparire a tutti i costi, anche quello del male. Quell’episodio di una voce “come di fanciullo, o di fanciulla” che canta “prendi e leggi, prendi e leggi” che getta Agostino in “una piena di lacrime” già di per sé ci dice quanto sia vero il principio di indeterminazione del Nobel Heisenberg, perché davvero lo Spirito soffia dove vuole, e soprattutto quando vuole. Proprio nel momento in cui tutto sembra perduto, lo scriveva l’insospettabile, raffinatissimo e un po’ dandy Proust, arriva il momento della salvezza. Un libro che mette i brividi ancora oggi è qualcosa di più di un dono: è la risposta alle sirene del male, nel caso di Agostino la tentazione del ritorno e della ripresa dei legami fisici – per lui ossessivi – e dell’orgoglio intellettuale, soprattutto il bisogno di primeggiare. Uno dei libri da comodino, avremmo detto un tempo, o da portare nell’isola deserta, o da donare, non solo a chi crede, ma anche e soprattutto a chi no, a che è in crisi, a chi senza volerlo si è incamminato nel buio scambiato per sfolgorio, del male.
Questo cammino di allontanamento dal male ha radici profonde, divenute punti di riferimento di tutto ciò che è venuto dopo: una di queste è incarnata dalle Confessioni di Sant’Agostino. Non solo perché questo libro di straordinaria auto-analisi, in anticipo di molti secoli su Freud, ha influenzato molta letteratura, anche quella non direttamente coinvolta nel progetto cristiano, come il “Tardi ti ho amato” di Ethel Mannin, (per non parlare del “Secretum” di Petrarca) ma in quanto rappresenta un vero e proprio cammino di terapia contro il male. Ecco perché questo libro prodigiosamente capace di parlare a tutti e in tutte le epoche andrebbe riletto ancora oggi. Ve ne sono diverse edizioni (quella in nostro possesso è una “antica” – 1989 – ristampa Mondadori curata da Carlo Carena, ma ve ne sono più recenti di Rizzoli, Bompiani, Newton Compton ed altri), con o senza il testo latino a fronte, che ci permettono di riprendere fiato nella corsa sempre più virtuale e solitaria nel bosco informatico, dove si nascondono i lupi cattivi della solitudine e della depressione. O dell’apparire a tutti i costi, anche quello del male. Quell’episodio di una voce “come di fanciullo, o di fanciulla” che canta “prendi e leggi, prendi e leggi” che getta Agostino in “una piena di lacrime” già di per sé ci dice quanto sia vero il principio di indeterminazione del Nobel Heisenberg, perché davvero lo Spirito soffia dove vuole, e soprattutto quando vuole. Proprio nel momento in cui tutto sembra perduto, lo scriveva l’insospettabile, raffinatissimo e un po’ dandy Proust, arriva il momento della salvezza. Un libro che mette i brividi ancora oggi è qualcosa di più di un dono: è la risposta alle sirene del male, nel caso di Agostino la tentazione del ritorno e della ripresa dei legami fisici – per lui ossessivi – e dell’orgoglio intellettuale, soprattutto il bisogno di primeggiare. Uno dei libri da comodino, avremmo detto un tempo, o da portare nell’isola deserta, o da donare, non solo a chi crede, ma anche e soprattutto a chi no, a che è in crisi, a chi senza volerlo si è incamminato nel buio scambiato per sfolgorio, del male.
E poi qualcuno dice che la letteratura non serve.












